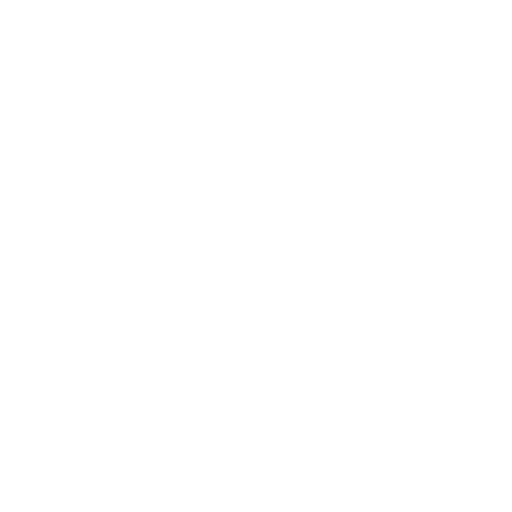INTERVISTA
Catia Bastioli, Presidente Novamont
Fare di più con meno, per una buona bioeconomia circolare
Dott.ssa Bastioli, da sempre si occupa di sostenibilità ambientale e materiali rinnovabili. Quanto si è fatto e quanto occorre ancora fare? Nell’ambito della bioeconomia circolare, ...
lunedì 1 febbraio 2021
Dott.ssa Bastioli, da sempre si occupa di sostenibilità ambientale e materiali rinnovabili. Quanto si è fatto e quanto occorre ancora fare?
Nell’ambito della bioeconomia circolare, negli ultimi 30 anni c’è stato uno sforzo verso lo sviluppo di bioraffinerie integrate, decarbonizzate e a zero scarti, per produrre bioprodotti a basso impatto ambientale, non cumulabili nell’ambiente e pensati per ridisegnare intere filiere. Quella delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, per esempio, in connessione con il rifiuto organico e l’agricoltura è un vero esempio di bioeconomia circolare in Europa, che ha dimostrato di poter rigenerare territori. Sostenere lo sviluppo della bioeconomia circolare nel nostro Paese è un’opportunità di rilancio dell’economia italiana nell’ambito del Next Generation Europe ma occorre uno sforzo di riprogettazione, trasformativo e multidisciplinare. Abitudini e spreco alimentari, catene agroalimentari e rifiuti, dovranno essere gestiti in modo sistemico, imparando a “fare di più con meno “. La logica circolare deve ridisegnare i sistemi di produzione, consumo e smaltimento, creare nuove forme di collaborazione tra settore pubblico, privato e terzo settore, portando sul mercato soluzioni coerenti che massimizzino le ricadute sulle comunità e la rigenerazione delle risorse naturali. Occorre incentivare lo sviluppo di nuovi processi chimici, biotecnologici e fisici per favorire il riuso di scarti e byproducts, adeguare le infrastrutture per il recupero e trattamento della sostanza organica e di altri fondamentali nutrienti presenti nel rifiuto organico, superare i limiti del end of waste, che ostacolano una piena attuazione della bioeconomia circolare. Oltre a favorire la creazione di codici ATECO, per dare dignità al settore della bioeconomia, e di nuovi indicatori, per misurare e monitorare le prestazioni dell’economia e della bioeconomia circolare.
La bioeconomia della società da lei guidata fonda le basi su: rigenerazione dei siti industriali dismessi, creazione e supporto di una filiera agricola sostenibile e un insieme di prodotti a sostegno dei problemi ambientali, economici e sociali. Carte vincenti grazie a una continua attività di ricerca ed innovazione. Quanto un maggior sostegno a favore della ricerca, da parte delle Istituzioni, impatterebbe positivamente sulla salute del nostro pianeta?
La ricerca scientifica è il motore dell’innovazione tecnologica, senza la quale non sarà possibile trasformare l’Italia in una società della conoscenza. La pandemia ci ha insegnato che i risultati della ricerca scientifica sono essenziali, non solo per far fronte a situazioni sanitarie emergenziali ma anche per dare le basi alle azioni delle istituzioni, evidenziando che nelle emergenze ci salveranno competenza e saggezza dell’uso dei mezzi tecnici. Ma in questa transizione, anche di modello di sviluppo, conoscenze scientifiche ed economico-umanistiche devono evolvere assieme, per creare un nuovo equilibrio tra sviluppo, uso delle risorse e riconnessione tra economia e società. Per rendere il Pianeta più resiliente è essenziale sostenere una ricerca multidisciplinare, transdisciplinare e partecipata, coinvolgendo anche le comunità in progetti di territorio per poter imparare sul campo. Solo così manager e imprenditori, investitori e istituzioni capiranno il valore del capitale naturale e della stabilità sociale, tanto da includerlo nei loro piani di sviluppo.
In una lezione per la “One planet school” spiega l’importante ruolo ricoperto dal suolo nella lotta all’inquinamento. Può spiegarci brevemente come avviene e che tipo di politiche occorrerebbe attuare per proteggere una fonte così preziosa per la salvaguardia del nostro pianeta?
La sostanza organica nel suolo (SOM) è composta da un complesso sistema di sostanze organiche parzialmente decomposte e gioca un ruolo fondamentale in molte funzionalità del suolo. Cambiamenti nella quantità o nella qualità di SOM influiscono sulla capacità dei suoli di garantire servizi ecosistemici, come il cibo, la biodiversità nonché la capacità di carbon sink, ossia di catturare il carbonio dall’atmosfera, contribuendo alla riduzione di emissioni climalteranti. I suoli Mediterranei son sempre più poveri di SOM, per proteggere una fonte così preziosa per la nostra vita bisognerebbe favorire e incentivare tutte le pratiche volte a riportare materia organica pulita in suolo, come l’utilizzo di compost di alta qualità da rifiuti solidi urbani. La soluzione al degrado del suolo è il limitato uso di sostanze fitosanitarie, unito a un forte sostegno verso l’agricoltura biologica e l’incentivazione dell’uso di principi attivi, quali biomolecole naturali a basso impatto unito all’adozione di prodotti ausiliari biodegradabili, frutto di filiere decarbonizzate.
Educazione, formazione e sensibilizzazione potrebbero essere le chiavi vincenti per rendere adulti e bambini più consapevoli e più attivi nella difesa del nostro Pianeta? In che modo?
Tutti possiamo contribuire alla tutela del Pianeta consumando meno risorse, diversificando abitudini alimentari, acquistando responsabilmente, producendo meno rifiuti alimentari, riducendo gli sprechi e facendo la raccolta differenziata. Il contributo da parte di scuola, Università, mondo ambientalista e municipalità sarà sempre più importante per un’educazione e formazione di qualità con approccio olistico, per promuovere una scienza partecipata, con esperienze e progetti sul campo, come catalizzatori di iniziative. La collaborazione attraverso i settori e il coinvolgimento dei cittadini sono al centro delle 5 Mission della Commissione Europea che nascono come un set di azioni coordinate, dirette verso la soluzione di quelle che sono state individuate come le 5 sfide dell’umanità, tra cui la Mission Soil Health and Food.